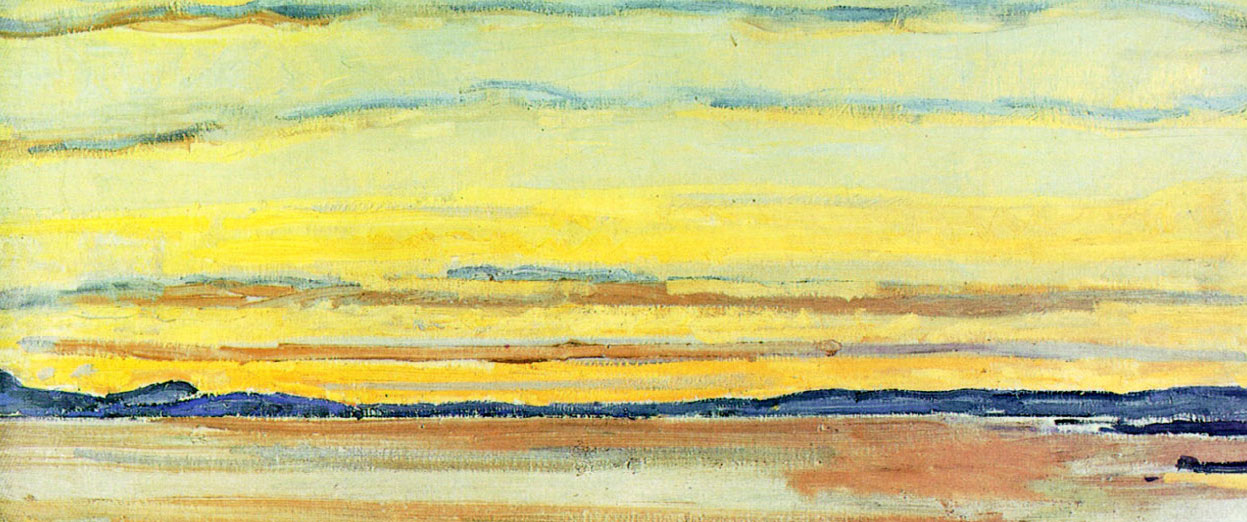
Ne “Il Poeta e la Fantasia”, (1909) Freud comincia scherzosamente riportando la richiesta che il cardinale Ippolito D’Este avrebbe mosso a Ludovico Ariosto, a proposito del suo libro “Orlando Furioso” : “Messer Lodovico, dove mai avete trovato tante corbellerie?” Dove attinge il poeta il materiale per le vicende che ci va esponendo? E come riesce a commuoverci così intensamente? Seguendo il suo interesse per le origini e lo sviluppo, Freud fa risalire la fantasia all’esperienza del gioco dell’infanzia. Per Freud l’arte era un territorio dove si poteva dare un appagamento illusorio ai desideri arcaici di un individuo. Winnicott riprende e sviluppa questo modello nella sua teoria dello spazio transizionale, “area intermedia che chiamo luogo di riposo perché quando l’individuo vive in quest’area non è impegnato a distinguere tra realtà fattuale e fantasia” Lo spazio transizionale è l’area del gioco, nella quale si possono unire le fantasie interne ed il principio di realtà. Il rapporto che l’area transizionale ha con la realtà è sostenuto da un apparente paradosso, che è poi il paradosso della creatività, la famosa domanda del Cardinale D’Este. “Il bambino crea l’oggetto del gioco ma l’oggetto era lì in attesa di essere creato e di venire investito dal desiderio.” (Winnicott, Gioco e realtà, 1971) È la mancanza di distinzione tra soggettività ed oggettività che rende questo spazio potenziale. Questa area di esperienza è utilizzabile durante tutta la vita, e non solo da bambini. È l’area, più in termini generali, dove si collocano nell’età adulta le esperienze culturali, quelle spirituali, quelle estetiche. E tornando a molti autori, è l’area del piacere “terribile” dato dall’arte.






